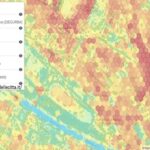di Paolo Degli Antoni

Il Piano del Verde e degli Spazi aperti, di seguito nominato PdV, approvato dal Comune di Firenze con delibera di Consiglio è un atto d’indirizzo emanato in coerenza con l’art. 8 “Ripristino degli ecosistemi urbani” del Regolamento UE 2024/1991 del Consiglio e del Parlamento, segnando un cambio di passo rispetto alla concezione otto-novecentesca del verde urbano, allora focalizzata sulla funzione ornamentale. La norma comunitaria, principalmente indirizzata agli agricoltori, chiede agli amministratori delle città di concentrarsi sulle funzioni ecosistemiche del verde urbano, incrementandone superficie e copertura arborea. La coerenza con la norma comunitaria apre peraltro le porte a (co)finanziamenti grazie ai quali l’investimento sul verde può essere incrementato rispetto alle serie storiche dei bilanci comunali.
Il PdV tratta il territorio urbanizzato distintamente rispetto a quello agricolo e forestale. In quest’ultimo, le aree verdi comunali di nuova istituzione sono individuate da apposite schede del Piano operativo approvato nel marzo 2024: ATs 01.13 Guarlone, ATs 01.14 Trespiano e ATs 06/07.10 Solliciano, sistema complesso comprensivo anche di produzioni agricole. Le tre aree summenzionate risultano in prevalenza classificate dalla carta dell’uso e copertura del suolo della Regione Toscana rispettivamente 242 – sistemi particellari compessi, 311 – bosco di latifoglie e 210 – seminativi.
A queste tre si aggiungono ulteriori nuove aree verdi nei subsistemi della pianura e della collina coltivate ai sensi del Piano strutturale vigente: ATS 02.14 Verde Jahier Dei Bruni, ATs 03.18 Verde Rusciano, ATs 04.12 Verde Assi, ATs 04.13 Verde Carraia, ATs 04.14 ex Campeggio, ATs 04.15 Verde Michelangelo e ATs 11.08 Montughi, con usi del suolo eterogenei, dal verde urbano, a colture agrarie diverse, localmente a bosco; non compaiono superfici con vegetazione in transizione arbustivo-arborea. Le aree prevalentemente agricole si prestano a incrementare l’agrobiodiversità locale, mentre la biodiversità naturale, di specie e di habitat, richiede la ricognizione delle aree che ne sono potenziale serbatoio (valli del Terzolle, del Mugnone e del Mensola, colline a nord e a sud, pianure a ovest, corridoi ecologici ripari) e l’indicazione di pratiche atte alla sua espansione, come la riqualificazione delle connessioni ecologiche deboli; in alcuni casi è sufficiente non accanirsi nella manutenzione del verde pubblico, ritardando lo sfalcio delle erbe e riducendo il numero di passaggi annuali; dove queste accortezze sono già attuate si vedono ricomparire anche in città specie erbacee (es. orchidee) e legnose (es. fusaggine) tipiche della campagna. Per quanto riguarda gli aspetti climatici, la campagna coltivata a seminativi e a oliveti non offre molto refrigerio alle contermini isole di calore urbane, ma intercetta bene la pioggia anche intensa ove il terreno è permeabile (alluvioni sabbiose e terrazzi fluvio-lacustri).
Successione secondaria
Un paragrafo dedicato a questo argomento segna un cambio di paradigma culturale impensabile vent’anni fa. Si riconosce il valore del “selvatico urbano” definendo un insieme di habitat ospitati in una data area, fornendo un’indicazione di ciò che potrebbe essere reperibile in potenza nelle aree incolte lasciate all’invasione spontanea della vegetazione e anche utili indicazioni per la ricostruzione della rete ecologica.
I boschi, anche di neoformazione, sono individuati nel territorio definito dalla tavola 12 “Verde agricolo e forestale”, ma non in quello urbanizzato, dove pure esistono. Inoltre non sono distintamente censite le aree con vegetazione in transizione arbustivo-arborea. Questo doppio standard, peraltro topograficamente incoerente con la zonazione del Piano strutturale e con quella “esclusiva o prevalente funzione agricola” della tav. 11 “Ecologia del territorio”, produce uno sfasamento tra la superficie forestale, pari all’8% del territorio secondo altri documenti comunali, e quella censita dal PdV, pari al 5,6%; manca all’appello il 2,4% costituito soprattutto da boschi di neoformazione interni al centro abitato, che sarebbero eccellenti aree di reperimento per nuovo “selvatico urbano”; a titolo d’esempio, si possono nominare due aree private abbandonate, ricolonizzate dalla vegetazione spontanea: i terreni agricoli adiacenti al lato ovest del Parco del Mensola e l’ex area estrattiva a Brozzi, che sarà però in parte occupata dallo sviluppo della tramvia 4.2 ATs 09.12. Alcune particelle confinanti con quest’ultima, per un totale di circa un ettaro e mezzo, sono di proprietà comunale, definite dalla banca dati delle subaree verdi “prato con arbusti”, ove si osservano anche giovani esemplari di specie arboree della flora locale; questi terreni sono definiti dal PdV “area inesitata”, di potenziale reperimento per una nuova area verde. Poco lontano un altro appezzamento di terreno comunale inesitato è ugualmente definito “prato con arbusti.

Esempio di aree inesitate con successione secondaria in corso
Dei boschi di neoformazione privati riconosciuti dal Comune, ricadenti nel “Verde agricolo e forestale” di cui alla tav. 12, paradigmatici sono quello già oggetto di studio ecologico comparativo di Trentanovi G., Campagnaro T, Kowarik I, Munafò M., Semenzato P. e Sitzia T. pubblicato su ELSEVIER nel 2021, sito in una vallecola prossima a via Bolognese, e quello affacciato su viale Aleardi, composto prevalentemente da roverella, leccio orniello e alloro, entrambi sul perimetro del territorio urbanizzato.

Bosco incombente su viale Aleardi, di neoformazione nella porzione inferiore con orniello e alloro
Dispiace che il PdV non tenga in debito conto del contributo conoscitivo prodotto dall’Accademia italiana di Scienze forestali, che censisce più generosamente i boschi di Firenze (circa 10% del territorio) evidenziandone l’incremento rispetto al secondo dopoguerra.
Il parco della piana
Il Comune di Firenze è incluso in minima parte nel Parco agricolo della Piana, comprendendo una minuscola porzione di ZSC/ZPS Stagni della Piana Fiorentina e Pratese in prossimità dell’aeroporto, i rimanenti terreni, ancorché non costruiti, sono inseriti dal PO nell’ambito dell’insediamento recente e saranno attraversati dalla tramvia 4.2; una parte di essi era fino a poco tempo fa occupata da un inceneritore; risultano due aree inesitate distinte in via di Bozzale. Il Piano strutturale prevede a est dell’aeroporto un grande parco complementare, potenziale occasione di forestazione urbana, tuttavia non ribadito dal PO né dal PdV, evidentemente per indisponibililità dei terreni.
Fonti di biodiversità
L’auspicato incremento della biodiversità si ottiene con l’accurata composizione della vegetazione nelle aree verdi urbane esistente e nuove, con la loro gestione senza accanimento ordinativo e con la predisposizione e la tutela di corridoi ecologici, riqualificando quelli più deboli.
La tavola 11 Ecologia del territorio evidenzia potenzialità e criticità. Il territorio comunale è ricompreso in quattro serie vegetazionali distinte, delle quali la più estesa in pianura; le aree collinari e vallive più ricche di biodiversità sono composte da ecosistemi non replicabili nella pianura urbana, che può essere arricchita in specie e habitat solo dalle confinanti simili campagne, anche grazie a corridoi ecologici costituiti soprattutto dal reticolo idrografico. La città è caratterizzata da specie e formazioni urbanofile o sinantropiche (es. piccioni, capperi, erbe interstiziali dei lastricati), la campagna da specie urbanofobe (es. primule, fusaggine), insofferenti agli stress provocati dall’intensa frequentazione umana (es. calpestio del terreno).

Erbe interstiziali dei lastricati e piantagione arborea a gruppo. Piazza del Carmine
La prossimità della campagna alla città, a sud e a nord di Firenze, consente tuttavia una certa espansione anche delle specie urbanofobe nei parchi urbani più prossimi e meno disturbati (es. fusaggine nei parchi di Rusciano e Ruspoli); il caso più spettacolare è costituito dalle orchidee selvatiche reinsediatesi nei parchi monumentali di Boboli, Cascine, Castello, la Petraia, Orto Botanico, il Ventaglio. Ophris x bobolensis è l’ibrido naturale reso possibile da questa ricolonizzazione.
Il demanio idraulico non è di competenza del Comune, Ente che perciò non può tutelare con normativa propria cogente la biodiversità di ecosistemi pregiati e di specie protette, come nel caso del deposito sabbioso presso il ponte Vespucci, habitat della specie Polyphylla fullo, smantellato dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno nel 2024.

Deposito sabbioso in Arno smantellato nel 2024, sul muro popolamento di capperi
Paolo Degli Antoni: Laurea in Scienze Forestali, conseguita presso la facoltà di Agraria dell’Università di Firenze. Abilitazione all’esercizio della professione di Agronomo-Forestale. Già funzionario C.F.S. e collaboratore della Regione Toscana, è socio corrispondente dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali, scrive contributi scientifici di ecologia del paesaggio, biodiversità, storia, arte e antropologia del bosco. Suo oggetto privilegiato di ricerca è la rinaturalizzazione.