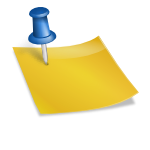di Giannandrea Mencini

Vigneti del Prosecco
L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) che svolge istituzionalmente importanti attività di consulenza e supporto tecnico scientifico al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, si è occupato spesso, attraverso numerosi quaderni divulgativi, della biodiversità in campo agricolo.
Questo importante organo scientifico ha sottolineato che l’intensificazione produttiva ha apportato “problemi di impoverimento e d’inquinamento del suolo, rischi sanitari e una perdita di diversità ecologica. Inoltre, è venuto a mancare lo stretto legame tra coltivazioni e allevamenti, utile nell’applicazione delle pratiche di letamazione, del riciclo dei residui colturali e delle rotazioni. L’uso poi dei diserbanti ha ridotto la presenza di vegetazione spontanea e la semplificazione degli ambienti ha determinato la scomparsa o l’allontanamento di specie faunistiche legate a determinate coltivazioni. Il diffondersi delle forme nanizzanti, a causa della necessità di rispondere a precisi criteri commerciali e requisiti agronomici, ha di fatto portato a un aumento eccessivo della produttività. L’abbandono dell’agricoltura tradizionale o dell’allevamento in collina e in montagna, ha causato dissesti idrogeologici per la mancata manutenzione del territorio”.
A fronte di queste preoccupanti considerazioni, ISPRA ha sostenuto che “la biodiversità, sia vegetale sia animale, può essere vista anche come processo evolutivo e di relazione fra diversità ambientali e culturali che comportano una grande varietà di prodotti agricoli e gastronomici connessi a un territorio specifico: salvare la biodiversità significa, quindi, salvare un patrimonio genetico, economico, sociale e culturale di straordinario valore, fatto di eredità contadine e artigiane non sempre scritte, ma ricche e complesse. La scomparsa di varietà o di razze si traduce in una rinuncia ai sapori autentici legati al territorio e alla cultura dell’uomo che ha saputo selezionare nel tempo questo variegato insieme di sapori e saperi.”
Da queste importanti valutazioni, riportate in rapporti non scritti da qualche ong o associazione di parte, ma da un importante ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente, è iniziata una mia analisi divenuta poi un libro d’inchiesta, sullo sviluppo delle monoculture nelle terre alte che coprono, vale la pena ricordarlo, il 76,6% del nostro territorio. La mia attenzione si è soffermata in particolare sullo sviluppo del prosecco nel nordest, delle mele nella Val di Non e dei noccioleti nel centro Italia, in particolare nel viterbese.

Noccioleti impiantati in prossimità di Orvieto
Si tratta di colture intensive che hanno portato in quei luoghi importanti riconoscimenti commerciali, occupazione e ricchezza nel territorio, ma anche criticità di natura ambientale e sociale, con una parte anche consistente della popolazione che ha protestato per questo proliferare di colture oramai industriali.
Infatti, oltre a causare una perdita della promiscuità agricola nel nostro territorio ricco di biodiversità, le colture specializzate richiedono anche inevitabilmente l’uso della chimica con conseguenze non trascurabili per l’ambiente circostante.
In generale, sulla base dei dati ricavati da Ispra fra il 2017 e il 2018 e pubblicati nel Rapporto nazionale pesticidi nelle acque (2020), diminuiscono a livello nazionale le vendite di prodotti fitosanitari per unità di superficie agricola utilizzata (SAU) – la media nazionale corrisponde a 4,3 kg/ha – ma si collocano nettamente al di sopra di questo valore il Veneto, la provincia autonoma di Trento, la Campania, l’Emilia Romagna e il Friuli-Venezia Giulia. Inoltre, in Veneto e Friuli-Venezia Giulia nelle acque superficiali le sostanze più frequentemente riscontrate sono erbicidi, il glifosato e il suo principale metabolita AMPA. Pure nelle acque sotterranee gli erbicidi tiazinici e i loro metaboliti sono tra le sostanze più rinvenute.
Questi dati sono in parte confermati anche dal successivo Rapporto Ispra pubblicato nel 2022 e relativo agli anni 2019-2020. Qui si legge che “nelle acque superficiali, la frequenza del superamento degli SQA (Standard di Qualità Ambientale) ha un aumento regolare, raggiungendo il valore massimo nel 2020. Le sostanze che maggiormente contribuiscono a determinare i superamenti sono il glifosato e il metabolita AMPA.” Inoltre, scrive sempre Ispra, “il rapporto tra le vendite e la SAU fornisce un’indicazione della pressione sul territorio esercitata dai pesticidi. Nel nord del Paese le pressioni sul territorio agricolo sono maggiori che al Centro-Sud. Le regioni che nel 2020 superano il valore nazionale sono: Veneto, Trento, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Bolzano, Piemonte, Sicilia e Lazio”. Sarà una casualità probabilmente, ma le colture specializzate da me studiate, come facilmente intuibile, ricadono nelle regioni appena ricordate.
D’altronde quando si punta sull’uniformità delle produzioni, ovvero quelle specializzate, giocoforza si va nella direzione di ridurre la biodiversità e allo stesso tempo si sconfortano i produttori agricoli a coltivare quei prodotti che il mercato è stato indotto a non richiedere.
Ma non tutto è negativo, anzi! Ci sono diversi esempi virtuosi nel nostro Paese che vanno in una direzione sostenibile dell’agricoltura, attenta alla storia rurale del proprio territorio, riducendo se non eliminando del tutto l’uso dei fitofarmaci. Queste aziende, queste persone, le ho incontrate nel mio “cammino” e mi hanno trasmesso utili informazioni e belle sensazioni.
Nel Veneto, precisamente a Sospirolo nella Valbelluna, ho incontrato viticoltori come Adriano e Giulia, due sorridenti giovani che vivono armoniosamente in questo idilliaco luogo e che non si sono fatti sedurre dal prosecco, arrivato anche in questa vallata. Adriano ha impiantato circa un ettaro a vigneto nel 2013, si trattava in gran parte di Pavana, uva autoctona, e di Bianchetta varietà sempre locale diffusa soprattutto nel Feltrino. Successivamente, delle due autoctone ha tenuto la rossa ed è passato a una varietà non locale resistente alle malattie in modo tale da non fare trattamenti. Si tratta di vitigni Piwi, incroci fatti in Germania poi alcuni in Svizzera e nel Nord Europa. I due giovani sono contenti, vivono in mezzo alla natura e hanno un loro mercato soprattutto locale.
Passando in Trentino, nell’alta Val di Non, a differenza della media e bassa vallata, grazie alla mobilitazione dell’associazione “Alta val di Non – Futuro Sostenibile” e dei produttori biologici “Amici della terra”, non si incontra la monocoltura delle mele. Qui, grazie a un’azione congiunta fra popolazione, sindaci e associazioni, sono state introdotte delle modifiche nella normativa di attuazione dei Piani Regolatori, per evitare la frutticoltura intensiva, ovvero l’infrastrutturazione in campagna. Ora nella alta vallata hanno puntato nelle produzioni biologiche e nella loro differenziazione: cereali, ortaggi, zootecnia e apicoltura. Inoltre, è attivo un proficuo rapporto con i GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) e si è valorizzato il bellissimo paesaggio e la biodiversità dell’ambiente circostante incentivando la presenza di un turismo consapevole ed emozionale.

Meleti in val di Non
In Molise, precisamente nel Comune di Castel del Giudice, provincia di Isernia, c’è un paese che rinasce e sta vincendo lo spopolamento con politiche basate sulla valorizzazione del territorio e la produzione di mele assolutamente biologiche e applicando con intelligenza una economia agricola diversificata e sostenibile. Una comunità rigenerata che ha conosciuto una innovazione sociale che l’ha portata ad abbracciare l’idea di un’impresa compartecipata e soprattutto biologica in grado di, parafrasando le parole del suo Sindaco Lino Gentile, aprire gli occhi e comprendere nonché valorizzare il grande patrimonio ambientale che la natura le aveva regalato. Anche in questo caso, il paesaggio con lo sviluppo dei meleti è stato trasformato ma qui, rispetto al Trentino, i campi ispirano un senso di naturalezza, mettendo in risalto la rinascita di un panorama che recupera i campi abbandonati e rigenera un’economia primaria storicamente radicata nel territorio.

Castel del Giudice
Ecco quindi che ritengo ormai inevitabile che in previsione delle grandi trasformazioni ecologiche e climatiche in parte già in atto, la nostra agricoltura dovrà essere sempre di più interessata a capitalizzare le qualità e le specificità dei prodotti locali, con produzioni diversificate e attente al rispetto ambientale, alla conservazione della biodiversità e ai valori culturali e sociali del territorio.
Giannandrea Mencini, veneziano, giornalista e scrittore, si occupa di storia dell’ambiente e del territorio. Ha pubblicato numerosi saggi, libri e articoli, dove ha raccontato i problemi della salvaguardia di Venezia e del vivere in montagna. Con il suo ultimo Libro “Pascoli di Carta. Le mani sulla montagna” Kellermann Editore (2021), dove ha indagato le speculazioni presenti negli alpeggi italiani, la cosiddetta “mafia dei pascoli”, è stato premiato a Leggimontagna Tolmezzo (UD) 2021, segnalato al premio Itas – Libro di Montagna, Trento 2021, e vincitore per la sezione saggi d’inchiesta del premio Internazionale Città di Como 2022.
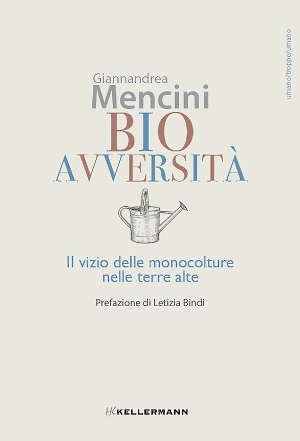 |
Giannandrea Mencini
BIO Avversità Il vizio delle monocolture nelle terre alte
Kellermann Editore |