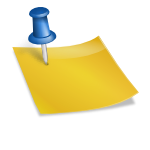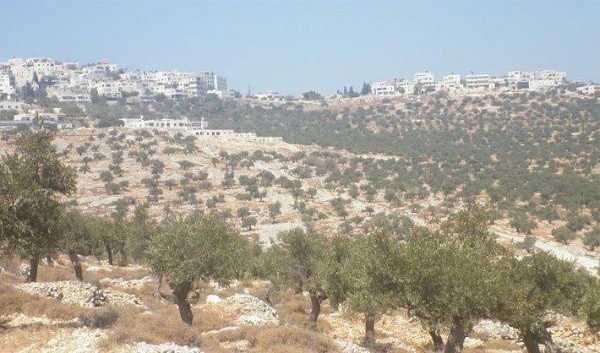di Antonio Saltini
Da quando i primi allarmi hanno dimostrato la capacità dell’agricoltura moderna di provocare alterazioni significative degli equilibri ambientali, nell’universo dei produttori agricoli si sono manifestati due atteggiamenti diversi per impiegare le risorse agrarie evitando di compromettere gli equilibri della biosfera: il primo ha suggerito un impegno ulteriore della scienza per la ricerca di pratiche capaci di superare il pericolo, il secondo ha immaginato un’agricoltura che rigettasse il contributi che alla crescita delle produzioni ha prestato, dalla metà dell’Ottocento, la chimica. Mentre gli agronomi convinti che la produzione agricola non possa ignorare i bisogni della popolazione del Pianeta si sono impegnati ad evolvere le tecniche tradizionali, gli adepti delle dottrine che, proclamando verità configgenti, pretendono di adempiere alla seconda istanza hanno rigettato le conquiste della tecnologia agronomica del secolo scorso nell’indifferenza per la caduta della produttività che ne consegue. Alla domanda di quale delle due filosofie stia disegnano l’agricoltura del futuro può darsi risposta rilevando che i cultori delle nuovi filosofie di palingenesi agraria ignorano le conquiste essenziali dell’agronomia occidentale, al primo posto il ruolo del bestiame bovino quale anello di congiunzione tra produzioni cerealicole e fertilità della terra: ignorandone il legato non pare verosimile che possano dirigerne l’evoluzione sulle fondamenta di un passato di cui solo ignoranza e presunzione possono disconoscere la solidità.
Un problema di proprietà lessicale
Tra gli storici la parola rivoluzione è un poco passata di moda: il gusto corrente suggerisce di impiegarla con parsimonia. Eppure il cultore delle vicende dell’agricoltura che si proponga di definire i processi che stanno modificando le procedure di coltivazione e di allevamento non può, forse, enuclearli in una locuzione più eloquente che “terza rivoluzione agraria”. La prima rivoluzione agraria è stata, notoriamente, quella settecentesca delle rotazioni di cereali e leguminose, la seconda è stata quella della chimica iniziata da Liebig e Lawes con l’impiego del superfosfato di produzione industriale e proseguita, in un crescendo travolgente, fino alla sintesi delle molecole a effetto ormonale. Possiamo definire come “terza rivoluzione agraria” quella che mira alle produzioni più elevate riducendo l’impiego di molecole di sintesi alle quantità minori compatibili con gli obiettivi di produzione, perseguendo, cioè, una tecnologia di impiego dei fertilizzanti e degli antiparassitari di sintesi che non comprometta gli equilibri dell’ambiente.
La conversione procede con lentezza. L’agricoltura deve provvedere all’alimentazione dei cinque miliardi di abitanti del Pianeta: rinunciare, prima che siano apprestate tecniche ecocompatibili egualmente efficaci, a quelle fondate sull’uso di sostanze che possono danneggiare l’ambiente, è scelta contro la quale si oppone una realtà tanto cogente da non consentire che violazioni marginali. Quelle violazioni non sono, peraltro, insignificanti: seppure scarsamente consistenti in termini quantitativi, non sono prive di rilievo sul piano delle percezioni e delle attese collettive. Sono le pratiche propugnate dalle scuole, o movimenti, per l’agricoltura “biologica” che tanta attenzione suscitano nella coscienza collettiva, e che nicchie non irrisorie stanno conquistando nel mercato dei prodotti alimentari.
L’impiego della locuzione “agricoltura biologica” impone, a chi si proponga di usare con proprietà il lessico scientifico, il ricorso alle virgolette: qualunque pratica agricola, anche quella che violenti più gravemente gli equilibri naturali, è applicata per dirigere e controllare processi biologici. Come la tecnologia più prevaricatrice, anche la pratica agricola più rispettosa degli equilibri naturali non manca di interferire sugli equilibri spontanei della natura. Produrre alimenti comporta la sostituzione di piante e processi biologici economicamente utili a piante e processi spontanei: la differenza è nell’intensità dell’alterazione, ma alterazione v’è comunque. Nell’uso del termine biologico per connotare pratiche agrarie diverse da quelle comuni è implicita, peraltro, per l’uso di una speciale enfasi espressiva, l’evocazione di una contrapposizione dalle palesi tonalità polemiche. Contro le regole del lessico, parlare di agricoltura “biologica” significa, nel linguaggio comune, parlare delle pratiche agrarie applicate da chi condanna come dannosa, all’integrità dell’ambiente e alla salute dei consumatori, la tecnologia invalsa presso la maggioranza degli operatori agricoli. Lo storico della scienza che rifiutasse la palese improprietà potrebbe, credo, definire le pratiche agrarie nate da quella condanna agricolture eteronome.
Se un imperativo cogente dirige, oggi, il progresso agricolo verso il rispetto degli equilibri naturali, vediamo quell’imperativo tradursi in due tecnologie distinte, in una pratica agraria che si evolve verso un maggiore rispetto di quegli equilibri senza rinunciare alla produttività acquisita, in una pratica alternativa che non accetta l’eventualità di alcuna interferenza negativa con la natura, che al dubbio dell’alterazione preferisce sacrificare la produttività. Ho compiuto, alcuni anni addietro, un breve itinerario nel pianeta dell’agricoltura “biologica”, credo sia più proprio dire delle agricolture “biologiche”, siccome il primo risultato della mia esplorazione fu la verifica di ampie divaricazioni di obiettivi e metodi tra scuole diverse, che mi apparvero divise dal più vivace antagonismo, per non dire da autentica rissosità. Al di là degli aspetti più coloriti il frutto della lunga serie di incontri fu constatare quanto poco i miei interlocutori ricorressero, per spiegare le proprie scelte, ad argomenti scientifici, gli argomenti con cui il tecnico di ogni sfera produttiva motiva i processi che applica. Le ragioni della scelta erano metascientifiche, ideologiche o vagamente etiche, attribuendo, peraltro, al termine una valenza alquanto diversa da quella consolidata da oltre due millenni di pensiero filosofico.
“Biologico” equivale a futuro?

È problema che può formularsi nei termini di un quesito: le pratiche dell’agricoltura “biologica” possono essere considerate tecniche d’avanguardia dell’agricoltura nel suo insieme? Superata l’antinomia della produttività, che le agricolture eteronome non erigono a obiettivo prioritario, la logica che sottendono sarà la logica dell’agricoltura di domani?
Propongo la domanda, riconosco di non essere in grado di una risposta inequivoca, credo di poter suggerire, tuttavia, alcuni elementi per procedere alla sua formulazione. In Italia non sono a conoscenza, innanzi tutto, dell’esistenza di istituzioni sperimentali, o di realtà aziendali, ispirate a un credo “biologico”, in grado di elaborare procedure dotate di carattere obiettivamente innovativo, tali, perciò, da orientare l’evoluzione dell’universo agricolo. Mi pare che risultati più significativi, verso l’apprestamento di pratiche compatibili con l’ambiente, realizzi la ricerca che non si qualifica con una professione di fede “biologica”: sottolineo i risultati sempre più fecondi che si registrano nella sfera della cosiddetta lotta “integrata”, una forma di produzione di frutta e ortaggi che ha consentito la drastica riduzione dell’impiego di molecole tossiche su superfici di assoluto rilievo. Per paesi diversi non dispongo di conoscenze sufficienti per avanzare un giudizio: ritengo auspicabile, a proposito, che qualche istituto di cultura agraria, e il compito spetterebbe piuttosto a un’accademia, o centro studi, che a un istituto agronomico, intraprenda la ricognizione delle esperienze estere necessaria a stabilire quanto le agricolture eteronome stiano operando per un obiettivo progresso scientifico.
Tra gli elementi di quella risposta non può mancare, comunque, la considerazione di un fattore capitale dell’attività agricola, la produttività. Ho riferito che i cultori delle agricolture eteronome dichiarano di anteporre la congruità, misurata secondo le rispettive concezioni, dei mezzi ad ogni finalità produttivistica. L’evidenza della scelta mi pare esoneri dalla ricerca delle proposizioni dottrinarie nei cui termini è formulata, che non sarebbe difficile reperire. Credo si debba ribadire, peraltro, che l’esito produttivo delle pratiche agricole non è variabile da potersi trascurare, in un pianeta popolato da cinque miliardi di esseri umani, dove la superficie coltivabile a disposizione di ogni membro del consorzio degli uomini si sta contraendo drasticamente, dove la produzione di cereali pro capite nei paesi sottosviluppati è immota, da anni, ai livelli caratteristici della sottonutrizione. Si può legittimamente dibattere sulla necessità di arrestare la moltiplicazione ulteriore degli abitanti del Globo, non si può negare che quanti uomini esistono, tutti abbiano diritto al pane, o al riso quotidiano.
Si può anche eccepire che un miliardo di uomini consuma, in termini biologici, più di quanto sarebbe necessario secondo standard nutrizionali rigorosi, ma è altrettanto vero che un miliardo di uomini soffre la fame. Generalizzare, oggi, pratiche agricole che riducano la produttività significherebbe moltiplicare il numero degli affamati: non so se debba reputarsi argomento comune dei cultori delle agricolture eteronome la risposta che il professor Ulrich Koepke, dell’Istituto per l’agricoltura biologica dell’Università di Bonn, proponeva, durante un dibattito ad Imola, alle mie osservazioni sulla disponibilità di cereali nel mondo: le carenze alimentari, sentenziava, sono un problema del Terzo Mondo, che non riguarda assolutamente l’Europa. Usando un’eloquente parola tedesca, non mi pare la prova della Weltanschauung di un grande scienziato.
Le grandi variabili dell’assetto del Globo paiono sottrarsi ai tentativi di regolazione razionale, o, è più realistico riconoscere, gli sforzi da cui ha preso forma la successione delle conferenze internazionali sulla popolazione, sull’alimentazione e sull’ambiente, le tre chiavi dell’assetto planetario, non sono state sostenute dal grado di intesa tra le nazioni necessario a stabilire rapporti nuovi tra la terra e i suoi abitanti. Se, comunque, l’impegno dovrà essere proseguito, e non può esservi futuro del Mondo senza la sua intensificazione, pare evidente che ove ci si proponga, stabilizzata la popolazione mondiale, di conservare gli ultimi spazi naturali, foreste e aree umide, evitando la loro trasformazione in aree agricole, sia necessario che le aree agricole siano utilizzate secondo canoni che ne sospingano la produttività. Non la produttività a qualunque condizione: la maggiore produttività compatibile con la razionale conservazione delle risorse, secondo i criteri che informano, ormai, inequivocabilmente, il progresso della tecnologia agraria.
Ma alla domanda sul contributo delle agricolture eteronome al progresso dell’universo agrario penso che una delle risposte più significative debba ricavarsi dalla considerazione della storia della tecnologia agraria, quella storia il cui corso ho enucleato, per gli ultimi secoli, nella successione di tre rivoluzioni successive. Quelle tre rivoluzioni sono state connesse da una logica cogente: la logica imposta dall’imperativo di comporre istanze scientifiche e istanze economiche. L’agricoltura non si è evoluta per caso o per capriccio, si è trasformata, usando i mezzi della scienza, dietro gli impulsi dell’economia. Abiurando, seppure con una gamma oltremodo variegata di opzioni, le acquisizioni della scienza, e sottraendosi, con una scelta di carattere etico, agli imperativi dell’economia, le scuole dell’agricoltura “biologica” si collocano fuori dal grande alveo della storia dell’agricoltura.
Antonio Saltini, giornalista e docente di Storia dell’ Agricoltura alla Facoltà di Agraria all’Università di Milano. Nel corso della sua attività come giornalista ha collaborato a diversi periodici ed ha diretto la rivista mensile di agricoltura Genio Rurale ed è stato vicedirettore del settimanale Terra e Vita. E’ autore della monumentale opera “Storia delle Scienze Agrarie” in 7 volumi.
 | Antonio Saltini – Storia delle Scienze agrarie |